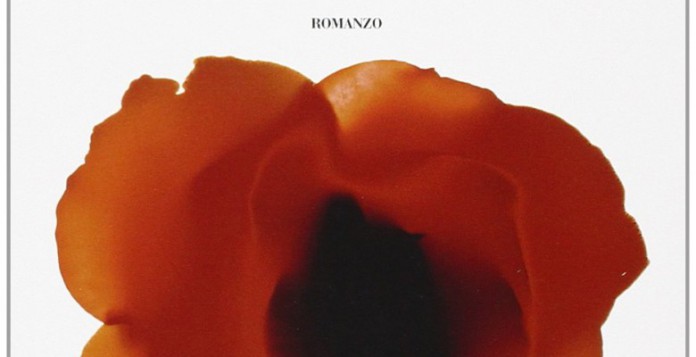
Un romanzo che è quasi un’inchiesta, Non chiedermi come sei nata (opera prima della giornalista culturale Annarita Briganti, Cairo editore, presentato ieri sera all’Antica Filanda di Roccalumera): un report crudo su ciò che significhi desiderare un figlio e non poterlo avere, con un orologio biologico che corre e una vita precaria (in amore, nel lavoro) fatta di amore per la scrittura, sveglie ad orari impossibili, e un paio di lavori altri, ‘di sostentamento’- perché si sa: litterae non dant panem.
“Tutto cambia dopo un aborto: non corro più, non scopo più”. Soprattutto se quell’aborto è spontaneo, e raschia via un figlio che non sapevi di aspettare. Così Gioia – giornalista freelance quasi quarantenne, sempre in servizio peggio di un medico, che ama i pasticcini e gli uomini sbagliati – si accorge di desiderare al di là di ogni cosa quel figlio perduto per caso. E la sua vita diventerà un inferno (esami clinici, interventi, bombardamenti ormonali, tentativi di fecondazione assistita: torture costose e dolorose e dall’esito incerto), fino all’impietoso verdetto finale, impossibile concepire. Sul quale si abbatte, a chiudere la questione, la ghigliottina della Legge 40, bigotta e contraddittoria, come solo in Italia, si sa, sanno essere le leggi quando vogliono. “Non ho più paura di niente” dirà Gioia alla fine “Cosa ci può essere di più spaventoso di non diventare madre?”.
Una narrazione veloce, incisiva, che guarda negli occhi il lettore, anche quando quegli occhi sono pieni di lacrime. Se fosse un romanzo rosa, la vita di Gioia apparirebbe melodrammatica: un aborto, un compagno sfuggente, un’infanzia affidata ad una tata, grande solitudine esistenziale. Ma questo, per fortuna, è “un romanzo fucsia, e in un romanzo fucsia arriveranno anche le soluzioni”: qui ogni cosa è filtrata dallo sguardo tenace e coraggioso di Gioia, che affronterà da sola il lungo dramma del non riuscire a diventare madre, regalando al lettore la versione del bicchiere mezzo pieno, colorando di positivo una vicenda altrimenti crudele e drammatica.
Ma la vera récherche del romanzo, a guardare bene, è quella di una famiglia. Lo dirà Gioia alla fine: “Odio gli addii e la solitudine, temo i cambiamenti. Vengo dalla classica famiglia disastrata, allargata, scombussolata. Sono cresciuta convinta che i sentimenti dovessero per forza essere confusi e infedeli”. Ecco che il termine famiglia diventa polisemico, e finisce per costituire il fil rouge che lega Gioia a tutti i personaggi del romanzo. Uto in primis, il compagno sbagliato: “Nonostante crisi depressive, psicofarmaci e gelosie, Uto mi faceva da famiglia”. E’ famiglia il ginecologo Andrea, per Gioia un autentico padre putativo; lo sono Anna e Luca, i migliori amici (“Noi quattro eravamo una bella famiglia”), e lo è soprattutto Alberto, alter ego attanziale di Uto: l’uomo dei sogni, friend with benefits, che appare come una visione e resta presente anche quando non c’è, e riscalda la vita di Gioia con la sua “assenza riflettente”.
“Ha nuove vite davanti, doveva solo trovare il coraggio di concedersele”. Gioia lo dirà di Anna, che aspetta un bambino, ma sa di ammonire se stessa: quella se stessa che ritroverà alla fine della storia, alla quale il cammino iniziatico lungo la via della (mancata) maternità avrà insegnato che “la vera rivoluzione è la normalità, accettare l’amore con la minuscola”. Perché anche se “gli uomini ti mollano all’improvviso dopo secoli, tradiscono e dimenticano la tua amicizia, si sposano per convenienza anche se amano te…ogni volta ne vale la pena, c’è sempre un altro mondo altrove”.
(Eliana Camaioni)








